EDITORIALE FARE L'INSEGNANTE N. 6 LUGLIO 2025

On ne change pas l’école par décret
Editoriale di Ivana Summa
Le radicali trasformazioni del mondo nel quale viviamo, che contiene chiari segni delle future e ancora più rapide trasformazioni, esigono altrettanti radicali cambiamenti nei nostri modi di ri-pensare tutti gli ambiti della società: l’economia, l’occupazione, la comunicazione, la cultura, la scuola, la salute, l’ambiente. Esigenze che oggi sono espresse ed intercettate in forme molto confuse e contraddittorie, tanto da generare un’incertezza del tutto nuova e particolare perché i modi di pensare restano, nonostante tutto, ancorati a quelli del passato. È paradossale, ma sta accadendo che si vogliono affrontare fenomeni nuovi e problemi vecchi negando le evidenze che la realtà ci mostra in tutta la sua crudeltà e cercando le soluzioni nel passato che appare perfetto e rassicurante. La lezione della pandemia di Covid 19 non è stata di nessuna utilità? Abbiamo dimenticato quanto ci è stata utile la tecnologia che ci ha consentito di continuare a lavorare, a studiare, ad avere relazioni; ha rinnovato lo spirito di sacrificio e di impegno, mobilitando le competenze professionali distribuite in tutto il mondo attraverso collaborazioni a diversi livelli. Tutti, specie gli esperti e i politici, sembrava avessero capito che, passata l’emergenza, era necessario implementare innovazioni di sistema in grado di affrontare un futuro che appariva e continua ad apparire sempre più inatteso e distopico. Le utopie, qui intese come ideali di un futuro migliore, non sono più di moda e, a quanto pare, è passata in subordine l’idea e la pratica di una via democratica alla visione del futuro, che si realizza come partecipazione consapevole a cambiamenti necessari.
Visione che, in tutto il mondo, non è più l’esito di una di una visione comune costruita insieme, bensì viene imposta per legge. Le vicende riguardanti le cosiddette nuove Indicazioni Nazionali, che hanno terminato il loro iter con il parere del CSPI del 27.06.2025 e stanno per essere emanate come Regolamento, sono l’esempio di come le scuole non siano considerate contesti di alta professionalità e, dunque, agenti di cambiamento. Lo stesso percorso normativo è stato avviato per la scuola secondaria di 2° grado per quanto riguarda tutti i suoi ordini di scuola. E Dio sa quanto sarebbe utile ricordare quanto ci ha insegnato Giancarlo Cerini che ha sempre posto l’accento sull’ aspetto metodologico della elaborazione delle riforme. Non crediamo all’efficacia di imprese riformiste, architettate da pochi pensatori o da commissioni di esperti, capaci di inventare soluzioni pret a porter. In proposito, Cerini aveva anche ideato fin dal 2006 la metafora della “ballata popolare” che è poi diventata di patrimonio pubblico nel mondo della scuola. Nel suo volume di quell’anno (Se la riforma fosse una ballata popolare) scriveva infatti “Ma chi decide del futuro della scuola? Il Governo pro tempore ha forse diritto a un progetto pedagogico compiuto, ad un suo modello di scuola? Ci piacerebbe dire che è solo la Repubblica ad avere diritto ad un progetto di istruzione pubblica. Occorre argomentare, leggere i bisogni del Paese, degli allievi, fare diagnosi convincenti, costruire una proposta avvincente… Non basta il programma di governo. Occorre avere un progetto, che poi si trasforma in una ‘ballata popolare’ dove gli attori e i ruoli si intrecciano; occorre fare chiarezza sulle risorse, sugli investimenti in formazione del personale: ricostruire motivazioni, condizioni di benessere, di soddisfazione, di incentivi al miglioramento; coltivare alleanze con i genitori, le comunità; prestare attenzione ai luoghi non formali dell’apprendimento”.
Partiamo da questo dato di fatto per spiegare il titolo che abbiamo dato a questo nostro ultimo editoriale dell’annata 2024/2025. Esso è un ricalco del celeberrimo saggio di Michel Crozier del 1979, dall’eloquente titolo On ne change pas la Société par décret. Certamente, lo studioso francese, grande esperto delle amministrazioni pubbliche, si riferiva soprattutto alla Francia di quegli anni, ma il suo pensiero è ancora di formidabile attualità. Credo che le sue riflessioni possano essere utilizzate ancora oggi e soprattutto per la scuola, in questi ultimi decenni sottoposta ad una serie di riforme, che piovono dall’alto piccole e grandi, ad ogni mutar di governo. Così, oggi, la scuola si trova ad affrontare da una parte, con tutta l’autonomia di cui dispone per legge e con la libertà di insegnamento connaturata alla funzione docente, i cambiamenti provenienti dai mutamenti sociali che entrano di prepotenza nelle nostre aule prima ancora che vengano intercettati e mediati dalle decisioni politiche e, dall’altra, deve applicare la normativa che, specie in questi ultimi anni, è molto prolifica ed interviene a tutti i livelli con indicazioni e “ricette” che restringono gli spazi di azione delle nostre scuole. Tutte queste norme vengono elaborate in modo sotterraneo e silenzioso, perché si esclude a priori la partecipazione delle scuole che hanno innovato profondamente il modo di essere e fare scuola per dare risposte a bisogni ed aspettative sociali e, soprattutto, di quegli insegnanti che, attraverso la ricerca-azione, sperimentano azioni educative e didattiche in grado di incidere efficacemente sui processi. Allora, torniamo a chiederci: davvero si può cambiare la scuola, il più complesso sistema organizzativo della pubblica amministrazione, soltanto par décret, per legge? Il recente libro dello storico Mario Isnenghi (Autobiografia della scuola. Da De Sanctis a don Milani, il Mulino 2025, pp.368), recensito da Flavia Marostica, intreccia magistralmente gli avvenimenti dell’epoca trattata con le storie degli insegnanti che in tutti quegli anni hanno attraversato con la valigia tutta la nostra penisola. Così emerge con chiarezza una originale autobiografia della scuola: «Cercando e ricomponendo i viaggi in Italia di cui è rimasta traccia, riaffiorano una storia autoriflessa di diverse generazioni di docenti, dinamiche soggettive dentro una rete precostituita di luoghi, di tradizioni e di obblighi, una costellazione di esploratori e testimoni d’epoca, manoscritti nella bottiglia che risalgono e ridiscendono la penisola; e alla fine, una storia molecolare d’Italia attraverso le vite e le relazioni dei docenti, le amicizie che si creano, i riflessi delle memorie» (nella Premessa p.9-10).
Ma di scuole che hanno chiaro di come si fa innovazione abbiamo testimonianza nel contributo di Bruno Lorenzo Castrovinci che focalizza le sue riflessioni sul docente innovatore: “Innovare per crescere, per migliorarsi, per contribuire con efficacia alla ricerca educativa, ma anche per rendere più bello e significativo il tempo scuola. Innovare significa riaccendere la passione per una professione che, giorno dopo giorno, costruisce il futuro”.
Anche Francesca Alemanno, pur incentrando il suo discorso sugli ambienti di apprendimenti innovativi, giunge al nodo centrale rappresentato dalla professione docente, metaforicamente rappresentata dalla figura dell’architetto. E, infatti, scrive: “L’insegnante in un’aula innovativa, come quella sinteticamente tracciata, non è più il "depositario del sapere" che riversa conoscenze, ma un "architetto di esperienze", un "coach" e "facilitatore". Questa non è una semplice evoluzione, ma una vera e propria ridefinizione identitaria che esige nuove consapevolezze. Senza una trasformazione interiore del docente, anche l'aula più avanguardistica rischia di rimanere solo un guscio vuoto.”
Infine, nell’invitare a leggere tutti i contributi, desideriamo mettere in evidenza il contributo di Pirchia Schildkraut che da molto tempo contribuisce ad allargare gli orizzonti della nostra rivista, mettendo a disposizione le competenze di medico, ricercatore e divulgatore. Il suo saggio, dall’eloquente titolo Il diritto globale alla salute: una questione di uguaglianza, ci fa capire come “la disuguaglianza, derivante dai fattori socioeconomici e dalle politiche nazionali, sia fortemente correlata con la salute individuale e pubblica. La visione olistica One Health si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente e questo richiede un approccio multidisciplinare”.
A questo aggiungiamo un’ultima personale riflessione: di uguaglianza, nel testo delle Indicazioni Nazionali 2025, si accenna una sola volta quando si riporta l’art. 3 della Costituzione italiana. X















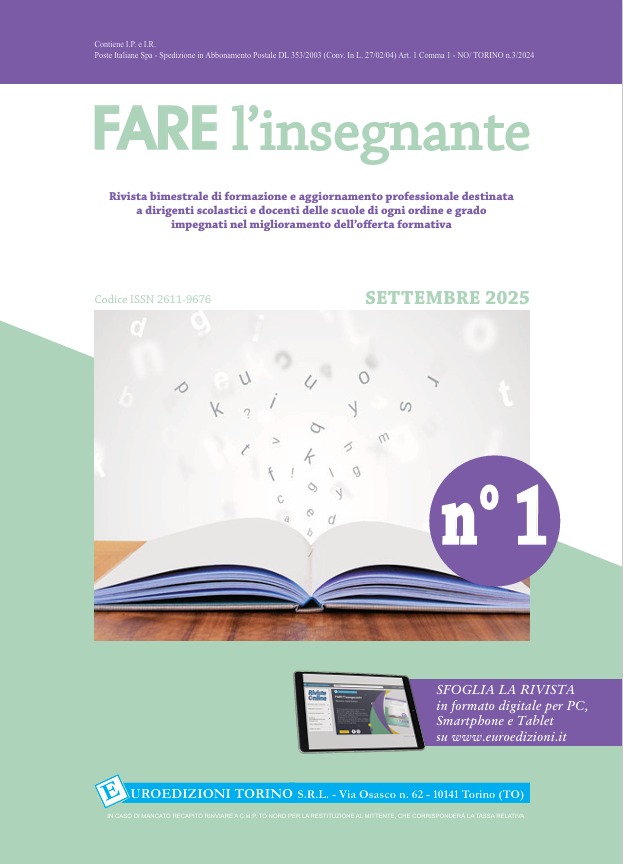

.jpg)











