EDITORIALE FARE L'INSEGNANTE N. 1 SETTEMBRE 2025

Si può regolamentare il volo delle farfalle?
Editoriale di Ivana Summa
Ho appena terminato di leggere i contributi che vengono pubblicati in questo primo numero che coincide con un nuovo anno scolastico e voglio riprendere alcuni passaggi fondamentali non per appropriarmene, ma per utilizzarli come categorie interpretative del cambiamento che continua ad abbattersi sul nostro sistema scolastico. Così, per il titolo, mi sono ispirata ad un passaggio del contributo di Stefano Stefanel dal titolo “Insegnanti e digitale”. Tale passaggio riguarda l’apprendimento informale, spesso non considerato dalla scuola e che, ormai da alcuni anni, è sempre più apprendimento dal digitale; infatti, scrive: “L’apprendimento informale oggi è per lo più digitale; quando ero bambino io era solamente esperienziale… la questione non è dunque che ruolo dare al digitale nella scuola, anche perché ce l’ha già: è una delle otto competenze chiave. Quello che si dovrebbe fare è, invece, capire entro quali spazi inserire spazi formativi, informativi, progettuali, programmatici. Compito che – a questo punto e con la macchina dell’Intelligenza Artificiale a pieno regime – non ha alcun senso realizzare per via regolamentare o per via curricolare. Scrivere oggi sul digitale e la digitalizzazione regolamenti d’istituto è perdere tempo e cercare di regolamentare il volo delle farfalle…”.
La questione rappresenta una categoria – quella del regolare, normare, regolamentare tutti gli ambiti educativi e didattici, terreno di autonomia scolastica e libertà professionale dei docenti – che sta prendendo piede nelle nostre scuole partendo dall’ipotesi che le farfalle – le nostre scuole e i nostri docenti – possano/debbano viaggiare in un’unica direzione e con un’unica coreografia. Ed è sotto gli occhi di tutti noi il profluvio di decretazione ministeriale che, anche durante l’estate, ci ha inondato. E, tanto per citarne alcuni, ricordiamo il divieto d’uso del cellulare durante tutto l’orario scolastico, le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche e le nuove disposizioni che regolamentano l’esame conclusivo del 2° ciclo d’istruzione, nostalgicamente denominato di “maturità”. È possibile fare formazione sull’utilizzo del digitale senza avere a disposizione i dispositivi; ignorare la presenza trasversale e pervasiva del digitale nella nostra vita quotidiana senza pensare alla necessità di progettare e sperimentare una didattica ibrida; e, infine, esiste davvero qualche professionista in grado di certificare seriamente la maturità di una persona a 19 anni?
Ma, è bene sottolinearlo a questo punto del nostro discorso, dobbiamo prendere in considerazione un’altra categoria apparsa nelle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione editate nel luglio 2025 ed è quella del magister con la quale la Commissione ministeriale ha inteso riabilitare, magicamente, la figura dell’insegnante. Nel testo si scrive: “Troppo spesso si dimentica che un insegnante è magis (da cui magister) “di più”, e che può essere volano del desiderio di apprendere di un allievo. Come tale, egli può diventare un punto di riferimento essenziale del percorso di formazione dello studente. L’allievo, infatti, è animato dal desiderio di imparare e sceglie una guida che sappia stimolarlo in tale direzione. E la funzione di “guida” assunta dal “magister” è fondamentale affinché il desiderio dell’allievo si orienti verso le esperienze e i contenuti del curricolo. L'espressione Magister vuole sottolineare l'autorevolezza ritrovata della figura del docente. È questo il presupposto essenziale per poter svolgere quella funzione di valorizzazione dei talenti di ogni giovane che è propria di una scuola che metta realmente al centro la persona dello studente”.
Nel testo c’è qualcosa che stride tra il desiderio spontaneo di imparare dell’allievo, la vocazione magistrale dell’insegnante e la valorizzazione dei talenti. Queste affermazioni sono così magiche da non richiedere nessuna formazione dei docenti orientata nella direzione indicata? A comprendere meglio cosa sia il magister ci aiuta Flavia Marostica con la sua recensione dell’illuminante saggio di Ivano Dionigi dal titolo “Magister. La scuola la fanno i maestri non i ministri”.
Come afferma l’autrice, “Il titolo e il sottotitolo focalizzano l’attenzione su un ruolo e un’istituzione. Il mio vecchio Dizionario Latino-Italiano (Angelini 1965) attribuisce alla parola Magister tre significati: 1) colui che comanda, che dirige, comandante, direttore, guida, sovrintendente 2) colui che insegna, maestro, precettore 3) consigliere, istigatore, eccitatore. Dionigi chiarisce nel Prologo che in un tempo di grandi cambiamenti come quello in cui viviamo gli adulti hanno la responsabilità di rendere responsabili e creativi i giovani offrendo loro il nostro patrimonio culturale in una scuola intesa come “palestra del dialogo… del confronto… dell’incontro” sicché magister “significa il superiore, colui che sa di più e conta di più e che si mette a confronto e in relazione con gli altri” e fa “il mestiere più bello, più importante, più misconosciuto del mondo”, anche se “oggi abbiamo sostituito il rispetto per i maestri con l’ossequio per i ministri”.
E potremmo aggiungere che la sfida del magister e dell’IA è tutta in mano ai docenti, propensi ad identificarsi con le discipline affidate al loro insegnamento, ponendo in secondo piano la funzione educativa che si fonda su una solida preparazione pedagogica. È pur vero che l’educazione ha tanti protagonisti nella società ma, come afferma Andrea Porcarelli, “In questo scenario, sarebbe logico aspettarsi che la competenza specifica nell’ambito delle scienze dell’educazione e della formazione (al centro delle quali, come vedremo, si colloca la pedagogia) fosse rivendicata con orgoglio come parte integrante della propria identità professionale, anche per distinguere il proprio lavoro da quella competenza educativa e formativa “ingenua” su cui tutti possono contare.
Invece, accade spesso il contrario: molti insegnanti sembrano pronti a prendere le distanze dalla pedagogia, quasi fosse un fardello inutile o un lusso accademico… Così facendo, però, rischiano di segare il ramo su cui essi stessi sono seduti. Rinunciare alla pedagogia significa infatti rinunciare a uno degli elementi che più qualificano il loro lavoro come autentica professione, distinguendolo da attività che, pur avendo valore educativo (come l’esperienza familiare o l’impegno associativo), non richiedono un sapere sistematico e una riflessione metodologica. “La delegittimazione pedagogica è una categoria utilizzata in modo diffuso e trasversale dalla politica ai media, trovando adepti in un numero consistente di insegnanti; tutto ciò comporta la mancanza di orizzonti di senso e di una chiara consapevolezza della funzione della scuola nella complessità dei fenomeni che strutturano la nostra società. È interessante quello che ci suggerisce il nostro pedagogista: per restituire nuova autorevolezza agli insegnanti/magister è necessario collegare la consapevolezza dell’identità educativa fondata sulla consapevolezza pedagogica di tutti i docenti.
Si tratta di “Riscoprire l’orgoglio pedagogico – per un insegnante o un dirigente scolastico - significa riconoscere che non basta “fare scuola”, ma occorre anche “pensare la scuola”. Significa comprendere che la pratica educativa non può ridursi a un insieme di tecniche o a una routine funzionale, ma trae senso e forza da un sapere che la illumina e la orienta. È questo che distingue un professionista dell’educazione e della formazione da coloro che possono contare solo su quelle competenze educative di tipo empirico ed ingenuo che derivano dall’esperienza di vita (e che pure possono essere una fonte significativa di criteri operativi … su cui bisognerebbe saper riflettere). Ogni volta che un insegnante riflette sul perché di una scelta didattica, sul senso di un contenuto culturale, sulla visione di uomo e di società che trasmette implicitamente con il suo modo di insegnare, si pone domande che sono – di fatto - pedagogiche… Riscoprire l’orgoglio pedagogico (“Pedagogic pride”) – per un insegnante o un dirigente scolastico – significa riconoscere che non basta “fare scuola”, ma occorre anche “pensare la scuola”.
E, aggiungiamo noi, è la scuola che deve esprimere il proprio orgoglio pensandosi come una farfalla che si sente libera di volare perché sa cosa sta facendo e dove sta andando. X















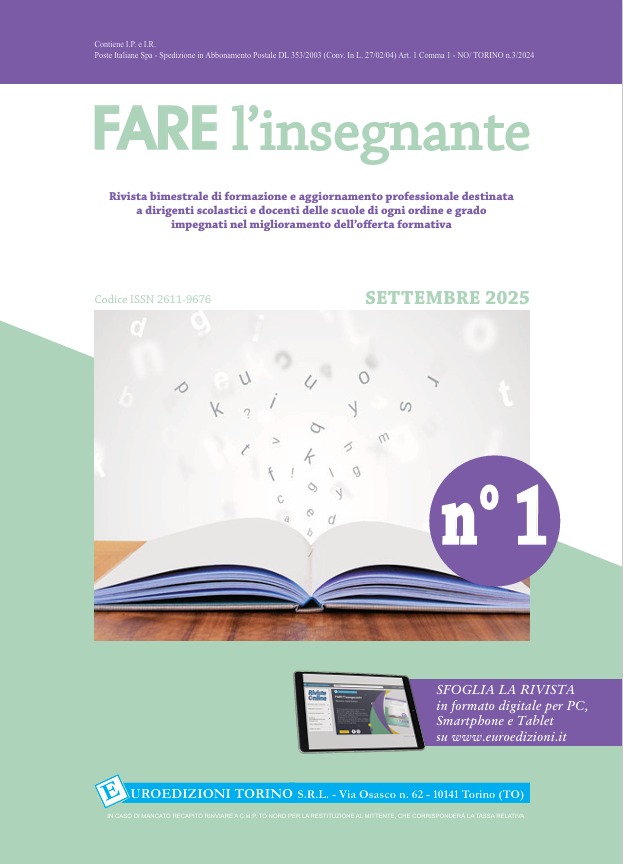

.jpg)











